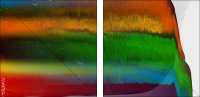La cerimonia della semplicità
In questo articolo ricordo con piacere ed un pizzico di emozione – anche se sono un po’ troppo giovane per lasciarmi andare ai ricordi — una particolare giornata ad Urbino risalente almeno al 2002. Durante un insolito workshop suddiviso in due distinti appuntamenti, Massimo Dolcini ci presentò due argomenti, con relativi relatori, inaspettati per una facoltà di design della comunicazione.
A distanza di qualche anno tutto ciò non mi sembra più strano, bensì totalmente geniale e capace di trasmettere un’incredibile senso di “speranza”. Di che tipo di speranza, vedremo in seguito. I due argomenti, suddivisi per mattina e pomeriggio erano la cerimonia del tè nella tradizione giapponese ed il «bon—tón» a tavola nella più classica tradizione occidentale. Geniale, non smetterò mai di dirlo. La più eccitante delle domande che mi pongo quando penso a quella giornata è: quanto tempo perdiamo appresso a mille superficialità? Leggi anche: cosa è davvero importante nella formazione di un esperto di comunicazione? Togli anche “di comunicazione”…
Comunque, passato un po’ di tempo mi rendo conto dell’incredibile valenza di quella giornata. Di come la focalizzazione che permea i nostri interessi quotidiani contemporanei sia così poco incentrata sui reali valori dei nostri stessi comportamenti e di come noi stessi “attori della comunicazione” non siamo assolutamente allenati ed educati in tal senso. Colpa di tanti educatori superficiali, «materialisti», prodighi di consigli generalisti e funzionalisti — incredibile, detto da me… — e incapaci a instillare il «fuoco sacro» che porta a indagare, eviscerare, cercare i valori e i significati dei comportamenti, delle persone. Le incongruenze, le particolarità dell’identità e tutto ciò possa risultare interessante per menti giovani da stimolare con una sostanziale dose di problematiche nuove & inespresse. Quasi morbose, azzarderei. Con metodo, per carità.
A questo punto spunta il senso di speranza instillato da quella giornata. Infatti proprio attraverso la capacità di leggere tra le righe, scavare dentro alla ritualità oppure al morboso attaccamento ad un’etichetta, un comportamento che soltanto seguendolo ti permette di «sedere alla tavola del signore» — per l’uso della «S» o «s» di quest’ultima parola, mi rimetto alla Vostra fantasia— si cela, a mio avviso, la capacità stessa di relazione tra le persone. Quello che volevano farci notare il Maestro della Cerimonia — che si chiamava Matsushita san, se ben ricordo — così come la gentile signora che presiedeva l’insegnamento dell’etichetta è la strutturazione logica di comportamenti più o meno sensati — agli occhi di una persona cresciuta a forza di tv, forse… — e la «cieca» fiducia che si dà ad essi. Sono particolari, forse, ma assolutamente parte di un tutto, senza di essi puoi anche fare a meno di bere un tè o cenare con gli amici — nessuno ci obbliga a farlo —. In soldoni, quando vai al fast food non segui un rituale né associ un particolare valore, ed è per questo che puoi farne a meno. Non riempie la tua vita, non aggiunge niente. (A chi pensa che fare la fila alla cassa faccia parte di un rituale tribal—metropolitano contemporaneo, invito a prendere visione della suddivisione tra i 4 attori della vita metropolitana di Jean Marie Floch e applicare a questo articolo la differenza tra un sonnambulo e l’esploratore) Cosa insegna tutto questo al designer della comunicazione?
?Prima di rispondere ci tengo a fare un po’ di pubblicità gratuita al libro che mi ha fatto tornare in mente questo evento. Tra le particolarità della cerimonia giapponese del thé c’è il rapporto tra il bevitore e la sua tazza. Essa non ha un enorme valore che però non ha niente a che vedere con l’oro o i diamanti o il denaro. Spesso è sbeccata, lavorata a mano. Una diversa dall’altra, sempre. I giapponesi tradizionalisti tengono molto alle proprie tazze, spesso conservate per generazioni, esse risalgono a centinaia di anni fa. Proprio questo particolare è riportato sul volumetto di uno dei più «stilosi» guru dei media contemporanei, John Maeda. Di origine — casualmente? — giapponese, insegna, come è noto, Media Arts Sciences al M.I.T. Il libro si chiama “Le Leggi della Semplicità” (blog) ed è edito in italiano da Bruno Mondadori e traduce in dieci leggi il procedimento dell’apprendimento dello studente ma anche quello dell’insegnamento da parte del maestro. Candidamente, sotto la voce della legge numero 5, ”Differenze: Semplicità e Complessità sono necessarie l’una all’altra” racconta di un giorno, in Giappone, quando viene invitato a prendere un tè da Ikko Tanaka, in compagnia di Shigeru Ban — non male come terzetto —. Come prima cosa mi informa che la cerimonia del tè si chiama chanoyu e poi analizza anch‘esso le tazze. Le chiama “ciotole profonde” e racconta: “Se mi ricordo bene, mi era stata assegnata una tazza del diciottesimo secolo che sembrava il frutto di un terribile incidente durante la cottura. Era una ciotola di ceramica profonda e di un nero lucido, le cui superfici esterne sembravano avvilupparsi in modo controintuitivo, come un quadro di Salvador Dalì. Non era per niente chiaro in quale punto della ciotola avrei dovuto appoggiare le labbra.” Dopodiché continua dicendo “… era palesemente imperfetta, priva delle semplici superfici lisce e bianche delle comuni tazze che vengono vendute nel reparto casalinghi dell’Ikea.” Conclude dicendo:“ A mio modo di vedere, la tazza simboleggiava, in maniera indiretta, l’essenza dell’estetica giapponese, sempre in cerca della perfezione assoluta. La sua inattesa complessità ha fatto sì che tutto il resto, già incredibilmente semplice, apparisse ancora più semplice.”?–
Nel complesso il libro è un’interessante visione sui comportamenti mentali da attuare in fase di progettazione. Interessante è anche la suddivisione per leggi — molto «americana», mi viene da dire, ma è oltremodo interessante — della semplicità, intesa sempre e comunque come fine da raggiungere — molto orientale, tanto per continuare con i luoghi comuni —.
Le leggi sono le seguenti:
1. RIDUCI Il modo più semplice per conseguire la semplicità è attraverso una riduzione ragionata
2. ORGANIZZA L’organizzazione fa sì che un sistema composto da molti elementi appaia costituito da pochi
3 TEMPO I risparmi di tempo somigliano alla semplicità
4 IMPARA La conoscenza rende tutto più semplice
5 DIFFERENZE La semplicità re la complessità sono necessarie l’una all’altra
6 CONTESTO Ciò che sta alla periferia della semplicità non è assolutamente periferico
7 EMOZIONE Meglio emozioni in più piuttosto che in meno
8 FIDUCIA Noi crediamo nella semplicità
9 FALLIMENTO Ci sono sempre cose che non è possibile semplificare
10 L’UNICA Semplicità significa sottrarre l’Ovvio e aggiungere il Significato.
Alla fine fornisce anche tre “chiavi” per l’utilizzo delle leggi:
A. LONTANO Più sembra meno: basta semplicemente spostarlo lontano, molto lontano
B. APERTO L’apertura semplifica le complessità
C. ENERGIA Usa di meno, ottieni di più.
A questo punto mi rendo conto di non aver ancora finito di rispondere alla domanda che mi sono posto in precedenza. Cosa serve al designer tutto questo? Se è vero che è stato questo il mestiere del secolo scorso ed è destinato ad evolversi ulterioriomente è necessario che sviluppi una buona dose di autosufficienza senza la quale non si sviluppa ma si adegua soltanto. Se è inoltre vero che progettare non è un processo che si svolge completamente su un tecnigrafo o al computer è bene capire DOVE vive il design. Anche rispondendo alla sola necessità di problem solving ed escludere la valenza socio—culturale della disciplina ci si incanala in un iter di ricerca, studio e conoscenza che porta inevitabilmente a maneggiare temi sociali e culturali, in quanto il campo d’azione è sempre comunicativo e di relazione umana. Quindi le conoscenze del designer non possono prescindere da questi temi. Sempre & in ogni caso. A questo punto bisogna solo capire quali posizioni assumere di fronte alla società. Aggressiva, compatibile, accondiscendente, passiva, propositiva, negativa, educativa… Niente di diverso dallo stesso comportamento umano.
A questo aggiungo anche questa frase del libro di Maeda: “Nel campo del design c’è la credenza secondo cui le migliori soluzioni nascono quando ci sono più vincoli.” È forse per questo motivo che quelli che ci vengono presentati dalle riviste di settore o negli annual come gli esempi migliori sono quasi sempre progetti nei quali il livello di libertà progettuale è molto alto e quando, come succede praticamente sempre in Italia, è necessaria una continua mediazione tra le idee di mille «saccenti» il risultato è sempre insignificante e dozzinale. A questo va aggiunto, per non liberare i progettisti dalle responsabilità, la quasi totale ignoranza di fronte a pratiche come quella sopracitata ed alla sua importanza nel «gioco» della progettazione e la conseguente incapacità di «insegnare» il proprio ruolo e di imporsi al «saccente» di turno. Dente avvelenato? Forse, ma forse anche il senso di soffocamento che un giovane progettista neanche trentenne vede come incombente nel suo futuro. Che fare? Ripartire dagli insegnamenti di qualcuno che aveva piacere di far crescere il designer come persone prima che come macchine ed insegnare che una regola viene sempre corretta da un fattore a lei estraneo, l’emozione.
--
Tutti i diritti sono riservati.